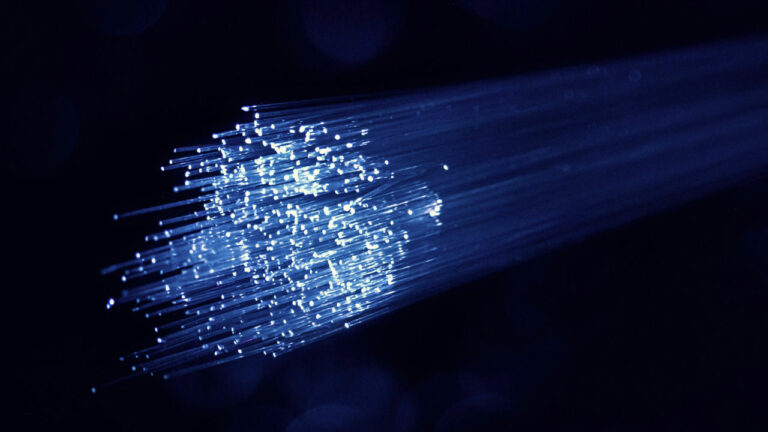Giustizia e PNRR – rischio restituzione fondi UE
Torna in primissimo piano l’annosa questione dei tempi -lunghi, anzi: lunghissimi- della giustizia italiana.
L’Italia, secondo l’ultimo articolo sul tema (su “La Repubblica”, del 6 luglio 2025), è in ritardo sul raggiungimento degli standard europei, e, soprattutto, è lontana dal raggiungimento della quota di abbattimento (dei giudizi più datati), secondo il Disposition Time pattuito in sede europea.
Il Ministro Nordio è dunque alla ricerca di soluzioni, e, nell’immediato, sembra orientato, secondo l’articolo di La Repubblica, alla ricerca di giudici che possano scrivere almeno duecentomila sentenze (dato riportato dal quotidiano citato in apertura), e, quindi, definire altrettanti giudizi pendenti.
Questo dato -duecentomila sentenze- andrebbe scomposto, tenendo distinti i provvedimenti “ritardatari” per ogni singolo grado di giudizio, e ciò perché l’attività demandata a ogni singolo magistrato, e nella quale rientra anche la stesura della sentenza (come atto finale del giudizio), è diversa per ciascun grado di giudizio, e richiede tempi di lavorazione che incidono sul quantitativo di provvedimenti finali che ogni giudice può ragionevolmente emettere.
Con riferimento al settore civile (solo apparentemente di minor impatto sociale):
- Nei giudizi di primo grado, anche quando si svolgono -ove possibile- con la trattazione cartolare (ovvero: con note scritte in luogo dell’udienza in presenza e della trattazione orale), i giudici devono gestire la fase istruttoria (ovvero, in via esemplificativa, valutare: se sentire i testimoni, e su quali punti; se nominare periti d’ufficio per la valutazione di aspetti prettamente tecnici); in ogni caso, devono valutare il contenuto degli scritti difensivi e dei documenti depositati dalle parti in causa, e solo in esito a questa fase (istruttoria) possono “trattenere la causa in decisione” e, come atto finale, scrivere la sentenza.
Sempre sui giudici di primo grado, inoltre, grava l’ulteriore attività di gestione dei procedimenti ante causam (per esempio: cautelari, o di accertamento tecnico preventivo) e dei procedimenti “monitori”, che danno luogo -in presenza dei presupposti di legge- all’emissione di un “decreto ingiuntivo”.
- In secondo grado, la fase istruttoria è raramente espletata, per le caratteristiche proprie del giudizio di appello; in questo grado di giudizio, infatti, la Corte di Appello esamina e si pronuncia solo sulle censure proposte dalla parte che instaura l’appello, e, almeno in teoria, i tempi potrebbero essere più veloci.
Ove richiesto, i giudici di appello devono comunque occuparsi delle istanze di sospensione dell’esecutorietà (ex lege) delle sentenze di primo grado, con il procedimento previsto dall’art. 283 del codice di procedura civile.
Spetta sempre al giudice dell’appello, infine, la decisione –ex art. 373 c.p.c.- sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di appello, se impugnata in Cassazione.
Va sottolineata, a proposito della giurisdizione di merito in grado di appello, l’attività di supporto (per lo smaltimento dell’arretrato rilevato nel 2012-2013) espletata dai giudici ausiliari di appello, di cui si dirà in appresso.
- Nei giudizi “di Cassazione”, l’accesso è rigorosamente limitato dalla corretta esposizione/censura dei vizi (della sentenza di appello) denunciabili, secondo quanto previsto dall’art. 360 del codice di procedura civile, senza che ciò abbia particolarmente inciso, negli anni, sull’accumulo di arretrato da decidere.
Dunque, occorrono giudici!, soprattutto per poter velocizzare il primo grado dei giudizi.
Questa necessità, ormai cronica, è stata più volte oggetto di provvedimenti legislativi, che hanno introdotto la figura della magistratura onoraria, reclutata al fine di supportare le esigenze del settore giustizia (grazie all’attività demandata a dipendenti statali o avvocati, con requisiti di anzianità e professionalità individuati dai singoli provvedimenti), senza tuttavia prevedere una contrattualizzazione stabile di tali figure.
Una particolare figura di magistrato onorario è stata istituita con il D.L. n. 69/2013, che ha previsto -e introdotto nella magistratura onoraria- la figura del “giudice ausiliario di Corte di Appello”.
Nell’ambito del quadro complessivo della magistratura onoraria, la figura del giudice ausiliario di corte di appello è stata introdotta con il precipuo fine di fronteggiare l’arretrato (decisionale) delle Corti di Appello.
A seguito delle operazioni successive al Bando (pubblicato nella G.U. del 9.9.2014, IV^ serie speciale), sono stati nominati di circa quattrocento giudici ausiliari (reperiti tra le fila degli avvocati, dei professori universitari, altri magistrati onorari o dei magistrati togati o notai, in pensione da non più tre anni), distribuiti nelle varie Corti di Appello e assegnatari -previo positivo espletamento di un periodo di tirocinio- di un proprio ruolo, composto da cause pronte per la decisione-redazione della sentenza.
Con sentenza n. 41/2021, tuttavia, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di tale figura (per contrasto con quanto disposto dall’art. 106, comma 2, Cost., secondo cui i giudici onorari possono essere nominati solo per le funzioni attribuite ai giudici singoli), stabilendone la (loro) tollerabilità -in presenza di riconosciute esigenze temporanee ed eccezionali, di pari valore costituzionale- sino all’adozione della riforma della magistratura onoraria e, comunque, con il limite finale del mese di ottobre 2025 (come previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 116/2017).
Gli attuali giudici ausiliari ancora in servizio, pertanto e nonostante la professionalità acquisita, sono ormai al capolinea della loro attività.
Ciò premesso, e osservato che la ricerca di giudici, da parte del Ministro, sembra essere maggiormente orientata verso il reperimento di giudici in pensione, o verso il reclutamento di giovani (magistrati) tirocinanti, nonché alla richiesta di “ritorno in campo” dei magistrati assegnati al Massimario della Cassazione, non può non osservarsi l’opportunità che, in questa fase critica, venga preso in considerazione il possibile apporto dei giudici ausiliari di corte di appello -nominati a seguito del D.L. 69/2013- ancora in servizio (o dimessi da non più di tre anni e comunque dopo il completamento, con giudizio annuale positivo, del primo quinquennio di servizio), che potrebbero essere assegnati presso le sedi di primo grado (anche per quanto riguarda gli uffici del Giudice di Pace, ormai quasi paralizzati dall’enorme quantità di giudizi pendenti), per la redazione delle sentenze (delle cause più datate), consentendo così ai giudici di primo grado la possibilità di dedicare più tempo alla gestione (e alla definizione) dei processi in corso.
Tale previsione di incarico agli (ormai prossimi) ex giudici ausiliari di corte di appello, peraltro, laddove strettamente collegata al raggiungimento di obiettivi prefissati (di tempo e di produttività) e con previsione di una remunerazione adeguata e commisurata al loro impegno, potrebbe anche essere svincolata dagli obblighi di stabilità previsti dagli standard europei, stante la temporaneità dell’incarico (la questione della stabilizzazione, infatti, è stata sollevata a fronte della plurima reiterazione degli incarichi).
In ogni caso, si osserva che il costo per detto incarico temporaneo o, in alternativa, l’eventuale stabilizzazione degli attuali giudici ausiliari di Corte di Appello, trattandosi di poche centinaia di soggetti (peraltro già qualificati, e dunque con possibilità di essere immediatamente operativi, senza necessità di attendere al tirocinio previsto dal D. Lgs. 116/2017) andrebbe valutata in confronto al costo che l’Italia potrebbe essere tenuta a sostenere nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi del Disposition Time.
In relazione alla stabilizzazione, va infatti segnalato che, a seguito della procedura di infrazione (n. 2016/4081) da parte della Commissione europea, l’Italia ha collegato alla manovra di bilancio 2024-2026 la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari (che per decenni hanno svolto le loro funzioni in stato di “precariato”, senza alcuna delle tutele riconosciute ai lavoratori in generale e ai magistrati professionali in particolare), tra i quali, tuttavia, non risulta compresa la figura dei giudici ausiliari di corte di appello (figura “inedita”, secondo la definizione utilizzata dalla Corte Costituzionale, nel panorama delle figure della “magistratura onoraria”).
Per le figure “classiche” della magistratura onoraria, con circolare del 31.3.2023, il Ministero della Giustizia ha disciplinato un regime transitorio, diversificato a seconda dell’anzianità di servizio e del tipo di rapporto (in esclusiva o meno).
A detta circolare è seguita l’emanazione della L. 51/2025 (che ha modificato il D. Lgs. 116/2017), che, in sintesi, ha riorganizzato la procedura di accesso e di conferimento di funzioni per la magistratura onoraria, destinata alla giurisdizione presso gli uffici del “giudice di pace” e presso gli “uffici per il processo” presso i Tribunali della Repubblica, con possibilità di assegnazione della trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale. Il In merito a quanto sopra esposto, Il Centro Studi Europeo chiederà di essere ascoltato in audizione informale presso le Commissioni permanenti del Parlamento.
Gabriela Napoli