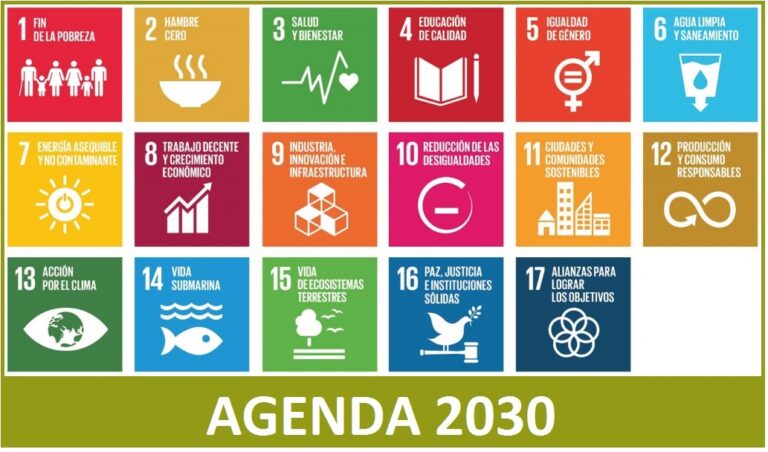Profili di danno erariale diretto e indiretto nelle società partecipate: responsabilità degli amministratori e dei sindaci, confine tra ente pubblico e società in house, azione erariale per malagestione
La gestione delle società partecipate dagli enti pubblici rappresenta uno dei campi più delicati e complessi dell’impianto giuridico contemporaneo, situandosi al crocevia tra diritto pubblico e diritto privato. La crescente diffusione di queste entità ha spinto dottrina e giurisprudenza ad approfondire i profili di responsabilità amministrativa e contabile, con particolare riguardo al danno erariale, sia nella sua forma diretta, in quanto derivante da atti gestionali illeciti, sia nella sua forma indiretta, in quanto conseguente all’omissione di controllo da parte degli organi di vigilanza o dell’ente pubblico partecipante.
Il presente contributo, partendo dal dettato normativo del D.lgs.19 agosto 2016, n. 175 (TUSP – Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), vuole analizzare, senza pretesa di esaustività, le ricadute che la gestione delle partecipate esercita sul confine tra diritto pubblico e diritto privato, con un focus sul ruolo degli amministratori, dei sindaci e sull’efficacia dell’azione erariale per mala gestio.
Tanto premesso, è possibile entrare nel merito della trattazione a partire dalla distinzione tra danno erariale diretto e danno erariale indiretto nelle società partecipate. Tale distinzione si fonda sul diverso modo in cui il pregiudizio si manifesta. In specie, si parla di danno diretto quando l’illecita condotta incide immediatamente sul patrimonio dell’ente pubblico socio; ciò accade, ad esempio, nei casi di conferimenti effettuati senza giustificazioni economiche oppure di acquisti di partecipazioni prive di utilità. Si configura, invece, un danno indiretto quando le conseguenze pregiudizievoli derivano in modo mediato dalla gestione della società partecipata, comportando ad esempio la necessità di interventi finanziari da parte dell’ente per fronteggiare le perdite quali il ripianamento delle perdite, il versamento di nuovi capitali o la rinuncia a crediti vantati.
Per comprendere appieno le dinamiche del danno erariale nelle società partecipate, è fondamentale operare una distinzione preliminare tra queste e le società in house. Il concetto di in house providing ha assunto un ruolo centrale nella disciplina delle partecipazioni pubbliche, in quanto consente di individuare quelle società che, pur costituite in forma privatistica, operano in sostanziale continuità funzionale con l’amministrazione pubblica. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la nota sentenza Teckal (causa C-107/98) ha individuato i due requisiti essenziali per qualificare una società come in house: il controllo analogo da parte dell’ente pubblico e la prevalenza dell’attività svolta in favore dello stesso.
Le società che soddisfano tali criteri sono considerate vere e proprie proiezioni organizzative dell’ente pubblico e, in quanto tali, ricadono integralmente sotto la giurisdizione della Corte dei Conti. In questi casi, la configurabilità del danno erariale è pressoché immediata, poiché le risorse gestite dalla società sono assimilabili a quelle direttamente amministrate dall’ente pubblico; di conseguenza, la responsabilità può estendersi anche ai funzionari dell’ente che abbiano omesso di esercitare il necessario controllo. Diversa è la situazione delle società partecipate ordinarie, ovvero di quelle che, pur essendo in parte detenute da enti pubblici, non soddisfano i requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente in favore dell’ente, e pertanto conservano una piena autonomia giuridico-organizzativa. In tali casi, il danno erariale non si configura come diretto, poiché la società, pur partecipata, rimane formalmente un soggetto di diritto privato distinto dall’ente pubblico. Il pregiudizio erariale si manifesta, piuttosto, in forma indiretta, ricollegandosi al deprezzamento del valore della partecipazione detenuta dall’ente o, più spesso, agli esborsi straordinari cui l’ente è costretto a far fronte per evitare il dissesto della società – si pensi, ad esempio, a ripianamenti di perdite, concessione di finanziamenti o rinuncia a crediti vantati nei confronti della partecipata. Tali interventi, resisi necessari a causa di una gestione inadeguata, antieconomica o addirittura contraria agli interessi pubblici, finiscono per tradursi in un danno al patrimonio dell’ente, rilevante ai fini dell’azione erariale.
Più nel dettaglio, le società partecipate ordinarie si caratterizzano per una partecipazione spesso minoritaria dell’ente pubblico, con un’attività rivolta anche al mercato e dunque aperta alla concorrenza. La disciplina cui sono sottoposte è prevalentemente quella del diritto privato, pur con l’applicazione di alcuni vincoli pubblicistici derivanti dalla natura del socio. Al contrario, le società in house sono sottoposte a un controllo da parte dell’ente pubblico analogo a quello esercitato sui propri uffici interni. La loro attività è svolta quasi esclusivamente a favore dell’ente controllante, senza una reale apertura al mercato, e la loro struttura normativa è fortemente ibridata da elementi pubblicistici. Proprio per questa vicinanza funzionale all’apparato amministrativo, i soggetti che le gestiscono sono assoggettati a forme di responsabilità più estese, spesso assimilabili a quelle degli organi interni della pubblica amministrazione.
Ne deriva che la responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate può configurarsi su due distinti piani. Da un lato, essi rispondono sul piano civile, secondo le regole generali previste dal codice civile: per le S.p.A. ai sensi degli articoli 2392 e seguenti, per le S.r.l. in base agli articoli 2476 e 2487. Dall’altro lato, gli stessi soggetti possono essere chiamati a rispondere sul piano contabile, quando le loro condotte producano un danno erariale – anche indiretto – al patrimonio pubblico investito nella partecipazione societaria.
In particolare, gli amministratori rispondono per decisioni imprudenti, negligenti o in violazione della legge o dello statuto sociale, mentre i sindaci rispondono per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori o per mancato esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli stessi. Sul punto, il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), all’art. 12, stabilisce un obbligo in capo agli enti pubblici soci di esercitare un controllo analogo e di attivarsi per la promozione di azioni di responsabilità ogniqualvolta emergano elementi sintomatici di danno o irregolarità nella gestione.
In tale contesto si inserisce l’azione della Procura della Corte dei Conti, che può essere esercitata nei confronti degli amministratori e dei dirigenti, qualora pongano in essere condotte gestorie antieconomiche, come investimenti non redditizi, stipula di contratti svantaggiosi o mancata adozione di misure correttive; dei sindaci, quando omettano i doveri di vigilanza e non attivino gli strumenti previsti per il controllo; nonché dei funzionari pubblici, laddove, pur a conoscenza di una mala gestio, trascurino i propri doveri di controllo, vigilanza e attivazione dei poteri di indirizzo sull’attività della partecipata. Tra le ipotesi tipiche di danno erariale, particolarmente rilevante è quella della ricapitalizzazione ingiustificata della società, effettuata per far fronte a perdite determinate da gestioni imprudenti o palesemente inefficienti, la mancata azione di responsabilità contro amministratori o sindaci responsabili di mala gestio; l’acquisto di partecipazioni non consentite o non coerenti con le finalità istituzionali dell’ente pubblico.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di società partecipate denota un’evidente tendenza all’ampliamento delle aree di responsabilità tanto per i soggetti interni alla società quanto per gli organi pubblici vigilanti. Il principio di accountability, sebbene applicato a soggetti formalmente privati, rappresenta il filo conduttore dell’intervento erariale.
La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito che il danno erariale, nelle società partecipate, rappresenta un rischio concreto e diffuso, che impone il massimo rigore nell’esercizio dei poteri di controllo e nella selezione degli organi societari. L’applicazione del D.lgs. 175/2016, integrato dalla disciplina anticorruzione (L. 190/2012), mira a ridurre le aree grigie e le occasioni di malagestione. In questo quadro, il rafforzamento delle azioni di responsabilità e dei controlli interni rappresenta un passaggio necessario per garantire la tutela delle risorse pubbliche e la corretta gestione delle società partecipate.
Vincenza Tiziana Costarella